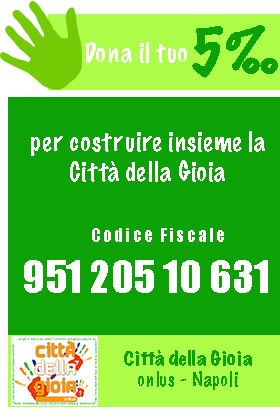I RANDAGI racconto breve di Agnese Pellegrini
In occasione dei 15 anni dell’Associazione Città della Gioia ETS di Napoli (nata nel 2009 come Onlus), si è pensato di dare voce a quanti ci seguono, sia nel volontariato sociale e culturale che sui social.
Abbiamo, allora, utilizzato lo strumento del concorso, che più volte ha destato molto interesse, favorendo l’organizzazione di eventi culturali (mostre, pubblicazioni, calendario tematico), anche a supporto delle nostre attività sociali.
La nostra è un’associazione che opera prevalentemente a Napoli. Ci è sembrato giusto, allora, sceglierla come tema (“Napoli, sequenza di luci. Tra passato, presente e futuro”), articolando il concorso nelle due sezioni fotografia sociale e racconto breve. Certi di trovare nella Città partenopea un “mondo” di rara ricchezza culturale, storica, artistica. Oggi – pare – riscoperta nel dopo-Covid, anche a livello internazionale.
Ringraziamo quanti hanno desiderato partecipare, anche fuori concorso. LA relativa pubblicazione ne raccoglie le opere, che sono espressione di una visione della Città capace di penetrarne storicamente le radici e di narrarne i valori e il vissuto, ma anche le problematiche. Il che ne fanno una realtà unica al mondo, pur ferita da ingiustizie del passato e del presente. E che – ci auguriamo – possa traguardare ad un futuro degno della sua Storia.
Per l’Associazione Città della Gioia ETS - Centro di Documentazione e di Comunicazione
Pasquale Salvio
IL RACCONTO BREVE VINCITORE DI AGNESE PELLEGRINI
I randagi
Alla fine, chi lo avrebbe detto che l’italiano l’avrei insegnato. «Pasquà», mi dicevano tutti, «tu ti devi imparare a riconoscere un Rolex. Solo se sei sicuro che è autentico, l’orologio te lo fotti. Altrimenti, fai come quei cagnolini che abbaiano, ma non lo portano a casa, l’osso…». Era così, che ci educavano negli anni ‘90, quando avevo 10 anni e vivevo in quei quartieri marginali di Napoli fatti di condomini-alveari, edifici incompiuti che volevano ispirarsi ai complessi edilizi della Costa Azzurra, ma che sono rimasti soltanto il deposito dei riscatti falliti, un ghetto di disagi, rabbia e abbandono. Eravamo uno sciame di bambini arruffati, che si muoveva compatto, come uno stormo. Non andavamo quasi mai a scuola, tanto nessuno ci controllava, gli adulti presi tra contratti precari, a nero e sottopagati. Passavamo le nostre giornate per strada, d’estate e d’inverno, in quel palcoscenico meraviglioso e dannato di dolori e tragedie, che è poi la parte più autentica di Napoli.
Sapevamo a malapena leggere e scrivere e l’italiano era qualcosa di sconosciuto, da usare solo nei quartieri alti. Con gli altri scugnizzi si comunicava in una lingua nostra, fatta di dialetto, ma anche di gesti e qualche grugnito. Del resto, allo stato brado vivevamo, e dagli animali avevamo imparato non soltanto lo spirito di sopravvivenza e di adattamento, ma anche il linguaggio. I nostri padri erano per lunghi periodi “ospiti” degli “alberghi statali”: a Poggioreale o in Puglia, quasi sempre, ma io e qualche compagno vantavamo di avere un genitore al Nord, a Milano. A volte, li andavamo a trovare, le madri ci costringevano a indossare i pantaloni lunghi e ci sistemavano i capelli, inumidendosi le mani di saliva e passandocele sulla fronte. Qualche cugino ci accompagnava alla stazione con un motorino (rubato e senza marmitta) su cui veniva caricata anche una enorme borsa, con melanzane alla parmigiana, frittata di maccheroni, una mozzarella di bufala gonfia di latte (che veniva sempre sequestrata all’ispezione, ma si continuava a portare) e un pezzo di pastiera.
Il viaggio durava anche 10 ore (ché non esistevano i treni veloci) e quando, ancora più sporchi e sudati di come eravamo partiti, arrivavamo a San Vittore - un edificio enorme, come la città in cui eravamo approdati - ci montava una timidezza e un senso di inadeguatezza sconosciuti nel nostro quartiere, che era colorato, pieno di voci che si rincorrono, di panni stesi, di audio delle televisioni sempre troppo alti, di panieri di vimini usati come carriole, odori di sugo a tutte le ore, mamme che urlano, pianti che scoppiano chissà dove, altarini a ogni crocicchio, dedicati a Madonne e santi più o meno inclini a concedere il miracolo, muri con affissi manifesti mortuari che sono una biografia, sedie di plastica abbandonate, come se quelle vie fossero un cinema all’aperto, per trasmettere il grande spettacolo della vita che solo a Napoli è così intensa, così viva, così gonfia di sostanza e di gusto: come la pizza di scarola, che piluccavamo in treno in quei lunghi viaggi, appunto, verso il Nord.
Fu in quel procedere sghembo e ciondolante della mia infanzia e della mia introduzione alla criminalità, che lo incontrai. Era nero, ma non di sporcizia. Aveva le pupille dilatate di paura, come quei soldi di cioccolato che ogni tanto ci regalavano alla Befana. Sembrava più o meno della mia età, ma mi superava di una spanna. Era randagio come me, ma non mi fidavo. Mi limitavo, quando gli passavo vicino, ad annusarlo, come fanno i cani. Trascorreva le giornate rannicchiato in un angolo, da solo. Aveva con sé una coperta, che proteggeva come un tesoro. Non lo avrei mai ammesso, eppure mi destava curiosità e nel contempo una tristezza infinita: noi del quartiere eravamo scapestrati, prendevamo ceffoni dalle nostre madri che ci lasciavano tatuaggi rossi sulla pelle… ma poi, alla sera, avevamo sempre un piatto di pasta al sugo per calmare lo stomaco e un letto su cui dormire. Lui stava sempre da solo. Sembrava apparso dal nulla. Sembrava il nulla.
«Iate, I mo' tengo a che fa», annunciai quella mattina ai miei compagni, che si stavano preparando a scendere al porto, per alleggerire le tasche dei turisti e poi trascorrere il pomeriggio a prendere il sole sugli scogli di Mergellina, dove il mare e il cielo hanno lo stesso colore. Non so perché, ma volevo capire chi fosse, quel ragazzo malinconico e sconosciuto. Mi avvicinai e lui mostrò i denti, come un ringhio, stringendo al petto la coperta. E fu allora che lo vidi: un libro, di grammatica italiana. Soffermai lo sguardo per un secondo di troppo su quel testo, dando al mio avversario un vantaggio di tempo, che lui sfruttò per svignarsela. Ci misi un attimo a riprendermi dallo stupore, ancora meno a trovarlo: conoscevo quel
quartiere come le mie tasche. Lo misi all’angolo e lui capì di non aver scelta. « E tu chi si?», gli chiesi. E allora parlò, come se la voce, a lungo trattenuta, avesse voglia di rompere gli argini, al pari del fiume in piena con la diga. «Mi chiamo Samir. Vi ho visto, sai, a te e ai tuoi compagni?», esordì. «Prima di tutto, però, dovete parlare l’italiano, e non il dialetto, io non lo capisco. Ho imparato la vostra lingua nei mesi in cui mi preparavo a venire in Italia. Mia mamma…», e in quel momento ebbe un tremito, «mi diceva che dovevo studiare e guadagnarmelo, il vostro Paese… Ma lei è morta prima di partire e mio padre è in carcere, da qualche parte…», il tremito divenne una lacrima, «e ora io non lo so se la voglio ancora, l’Italia… Sono scappato per paura, una volta approdato in Sicilia, e sono arrivato qui non so come, a nessuno interessa di me». Le sue parole erano uno scroscio di pioggia abbondante. E, come acqua fredda, quel racconto mi risvegliò.
Sapevo che don Carmine, il nostro parroco, cercava di dare una mano ai ragazzi di strada e a qualche sparuto immigrato che, negli anni 90, iniziava ad arrivare anche a Napoli, dalla Tunisia. Lo sapevo perché mille volte eravamo stati scovati da quel sacerdote che, allettandoci con qualche caramella o un pallone nuovo, cercava di spiegarci che dovevamo andare a scuola, l’unico modo per non fare la fine dei nostri padri, che poi era la fine migliore, perché l’alternativa era prendersi una pallottola in testa e schiattare così, a nemmeno 20 anni. Io capivo che non era cattivo, che quello che diceva era anche giusto… però poi continuavo a pascolare con gli altri bambini, perché era più semplice e rassicurante, la legge del branco. Tuttavia, in un attimo compresi che se volevo aiutare Samir, o come diavolo aveva detto di chiamarsi, era proprio da lui che dovevo andare.
Era più alto di me, ma io ero più forte e robusto. Presi il libro, la coperta e il suo braccio e, risoluto come mai ero stato, lo trascinai per quelle strade, fino alla chiesa. Non oppose resistenza, era rassegnato, o forse aveva speranza. Nonostante tutto. Non ero la persona che più ispirava fiducia, me ne rendo conto, ma lui solo me aveva per salvarsi. E, lo capii dopo, io solo lui avevo per salvarmi.
Se il parroco fu stupito di incontrarci tra i banchi della chiesa, non lo diede a vedere. Sapevo chi era, perché spesso appariva in televisione, in quei programmi dove tutti parlano del nostro quartiere. Ma nessuno ci vive. Era una brava persona, una di quelle che si impegnano coi fatti, e non con le parole, e che sarebbe stato identificato, negli anni successivi, come un “prete di frontiera”. Per questo, lo rispettavamo, anche se non lo seguivamo. Non disse niente, e lo apprezzai. Chiuse i battenti della parrocchia, e ci invitò a seguirlo in sacrestia. Ci mise davanti un succo di frutta e qualche dolcetto, sui quali io mi avventai goloso, Samir con riluttanza. Come iniziammo a parlare, non lo so nemmeno io. So solo che rimanemmo lì tutta la mattina, e poi tutto il pomeriggio, e che quando tornai a casa presi una quantità di ceffoni inenarrabile. Samir invece non tornò nel suo angolo di strada, rimase a dormire da don Carmine. E rimase da lui finché non fu affidato, come minore non accompagnato, a una famiglia di Posillipo, dove presero a chiamarlo Salvatore e dove ebbe tutto quello che avevano i figli dei chiattilli.
Io andavo a trovarlo, spesso. Gli insegnavo qualche espressione dialettale, lui mi faceva amare l’italiano, materia in cui era bravissimo. Mi misi a studiare, con impegno. Presi la licenza media e poi proseguii. Anche Samir proseguiva con successo i suoi studi e vinse una borsa di studio per frequentare l’Università di Medicina, a Milano. Andai a vedere come si fosse sistemato, e mi meravigliai di quanto bella fosse quella città, che da piccolo mi sembrava grigia e lontana. Ma, del resto, io avevo conosciuto solo il carcere di San Vittore. Mi chiese di rimanere con lui, e fui tentato di accettare. Ma sapevo che il mio posto era a Napoli, nel mio quartiere.
Quando presi il diploma di maestro elementare, alla cerimonia c’erano tutti: don Carmine, mia madre, mio padre che era tornato con noi e aveva scelto di prendersi una “pausa” dal suo lavoro abituale, e qualche mio vecchio amico, di quelli che erano rimasti. La scuola dove insegnavo era fatiscente e angusta, ma io mi sentivo nel posto giusto. Il primo giorno di scuola, al primo banco c’era un ragazzo nigeriano: con la faccia rotonda come il sole, due occhi vispi contornati da una montatura di occhiali dorata. Gli chiesi di ripetere la lezione che avevo appena dettato; mi ricordava Samir, anche se era più spavaldo e meno dinoccolato. Nutrivo grandi aspettative su quel bambino; lui però fece scena muta. Rimasi sconcertato e lo fissai accigliato. Di rimando, mi fece l’occhiolino, schioccò la lingua e mi disse: «Uè, maè, meglio nu ciuccio vivo, ca nu duttore muorto».

MARE FUORI…
La bellezza del Golfo… come cornice o abbraccio dell’ Isola che non c’è»
… Nisida… Dove il mare bagna anche il Carcere minorile, con le sue storie di dolore e di
speranza… (dal Calendario 2025 di Città della Gioia ETS “Napoli, chiaroscuri”)